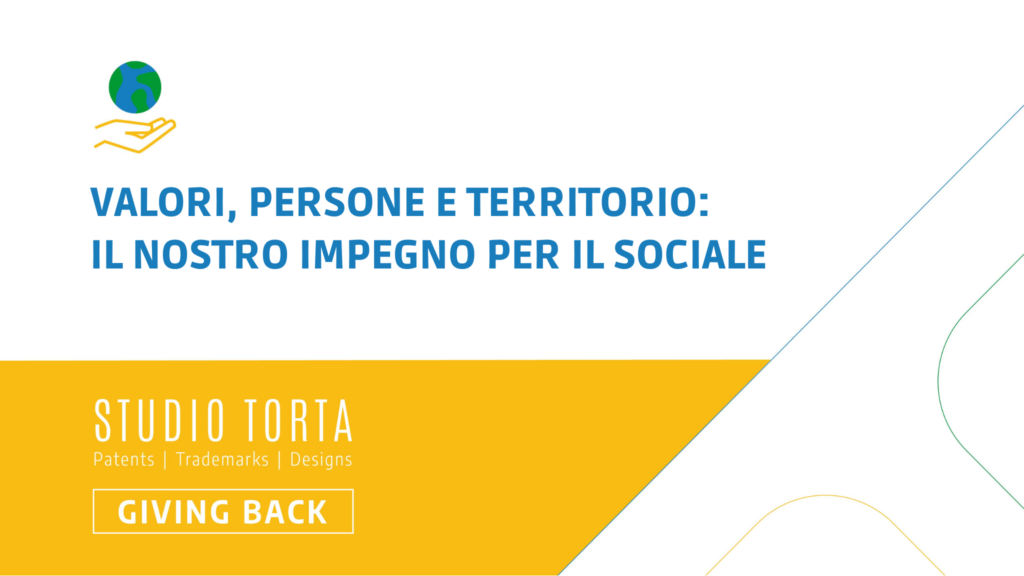La nuova legge italiana sull’Intelligenza Artificiale
Lo scorso 18 settembre è stata ufficialmente licenziata dal Senato la nuova legge italiana sull’intelligenza artificiale (IA), che ambisce ad essere la prima legislazione nazionale a governare, in coordinamento con il regolamento (UE) n. 1689/2024 (c.d. AI Act), la complessa materia dell’IA in Italia.
In testo, composto da 4 capi e 26 articoli, ha subito diverse modifiche dalla prima versione contenuta nel disegno di legge del maggio 2024, in modo da allinearsi alla normativa europea.
Gli aspetti più interessanti sono:
- La scelta di individuare nella AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e nell’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) le autorità nazionali per l’IA.
- La scelta di escludere le attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione, applicazione e utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale svolte a fini di sicurezza nazionale;
- La volontà di consentire e favorire l’utilizzo di sistemi di IA in ambito sanitario, compreso lo scopo di ricerca e sperimentazione, nel rispetto di principi fondamentali come non discriminazione, trasparenza, antropocentrismo, accuratezza e sicurezza dei sistemi e della normativa sulla privacy.
Tuttavia, per quanto di interesse, l’aspetto sicuramente più rilevante è stata la modifica alla legge 633/1941 sul diritto d’autore (lda).
La nuova legge sull’IA, oltre ad aver introdotto nell’ordinamento dei nuovi articoli relativi alla esenzione text and data mining (TDA) già introdotta a livello unionale dalla Direttiva Copyright del 2019, ha aperto alla tutelabilità delle opere anche ove create con l’ausilio di strumenti di IA, sempre che il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile modificando l’art. 1 della lda.
Questo sembra dunque confermare quella prima, timida, apertura stabilita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1107/2003 dove era stato affermato, tra il resto, che l’utilizzo di un software per generare un immagine è circostanza compatibile con l’elaborazione di un opera di ingegno purché sia presente un tasso di creatività da scrutinarsi caso per caso, e, dall’altro, quanto già stabilito da casi dell’European Patent Office (EPO) in virtù dei quali si devono negare i diritti a opere create esclusivamente da sistemi di IA, senza l’intervento umano.
I prossimi mesi saranno estremamente interessanti. Siamo di fronte a un nuovo tassello normativo che, in assenza di normative specifiche in altri paesi, contribuirà all’interscambio culturale con le altre legislazioni. E infatti, se in Cina ci si basa, al momento, su una sentenza del Beijing Internet Court per cui servono circa 150 prompt per dimostrare un contributo umano creativo e rilevante, e negli USA l’Ufficio Copyright ha affermato che un solo prompt non è sufficiente, il problema comunque non ha raggiunto una maturazione tale da poter essere ritenuto risolto.
Da noi, sicuramente, occorrerà dare in primo luogo risposta a come si possa giudicare questo “contributo umano creativo, rilevante e dimostrabile”: lo si farà secondo le regole relative all’atto creativo, seppur minimo, tipiche della creatività della legge sul diritto d’autore, oppure in modo diverso visto che non vengono utilizzati gli stessi lemmi?