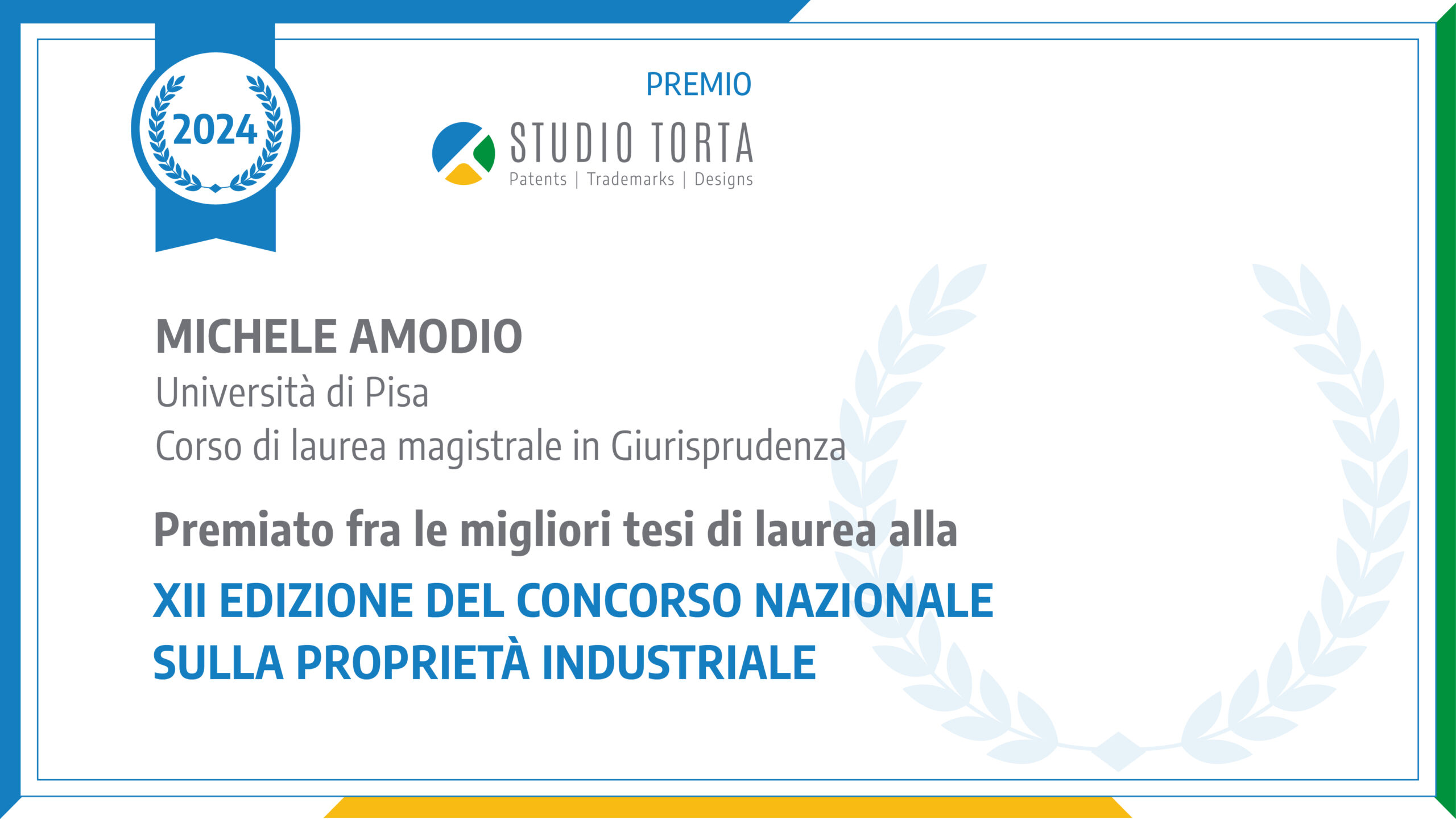I brevetti standard- essential tra diritti di privativa e potere di mercato
Il rapporto potenzialmente conflittuale tra diritto della concorrenza e diritto della proprietà intellettuale riflette una intrinseca tensione concettuale tra due scopi apparentemente inconciliabili. Il primo, dal canto suo, si propone di garantire che gli equilibri del mercato siano frutto di una libera competizione tra le imprese che trovi nel merito il suo fondamento e che si rifletta nell’offerta di migliori beni e servizi per i consumatori finali. A tale scopo, l’attività del legislatore e degli operatori del diritto si propone di incentivare la partecipazione al mercato e di rimuovere, per quanto possibile, eventuali barriere all’ingresso. Il secondo, sotto diversa prospettiva, promuove la valorizzazione dell’inventiva personale e della ricerca tesa all’innovazione, garantendo, in ottica premiale, l’esercizio di un potere monopolistico al soggetto fautore dell’invenzione, il quale può sfruttare in esclusiva i propri ritrovati o imporre a soggetti terzi il pagamento di un canone per avervi accesso.
Nonostante tali divergenze nei fondamenti di partenza, è possibile sostenere, a ben vedere, che entrambi i rami del diritto convergono verso la propensione a favorire l’innovazione dinamica ed a premiare il merito degli attori economici, sposando entrambi l’ambizione di disincentivare comportamenti opportunistici di sfruttamento. Se, infatti, il diritto della concorrenza, o antitrust secondo la definizione preferita oltreoceano, si propone di garantire che la competizione nel mercato sia equa e basata sulle risorse di cui ciascun operatore legittimamente dispone, sanzionando le condotte che alterano il libero gioco concorrenziale, in un’ottica affine le norme di proprietà intellettuale impediscono il free riding, evitando che soggetti terzi si arricchiscano sfruttando le scoperte e gli investimenti portati a termine da altri senza che questi ottengano un adeguato compenso.
Come si può intuire, assicurare un ritorno economico che consenta di recuperare i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo non è solo coerente nella prospettiva del riconoscimento del lavoro svolto, ma rappresenta un fondamentale incentivo per le imprese a continuare l’attività di sperimentazione, con il risultato di mantenere viva quella tensione all’innovazione i cui benefici ricadono anche sul mercato e sui consumatori. Questa prospettiva è particolarmente significativa nel caso dei brevetti e notevole è il peso specifico che le attività legate alla vendita, allo scambio e al possesso dei brevetti ricoprono all’interno delle politiche industriali e delle scelte di investimento. L’impiego di tecnologie o di prodotti coperti da brevetto può conferire ad un’impresa un forte potere di mercato, potendo questa contare su un asset che, in virtù dello jus excludendi garantito dall’ordinamento, conferisce un vantaggio competitivo sui concorrenti che non vi hanno accesso. Per comprendere quella che potrebbe essere definita la portata quasi-concorrenziale di un brevetto è, dunque, necessario osservarne non più solo la natura di fine, cioè di strumento giuridico all’interno del quale cristallizzare una propria invenzione, ma anche quella di mezzo attraverso cui il titolare può battere la competizione dei concorrenti nel mercato di riferimento.
In quest’ottica si comprende il perché della corsa delle imprese alla brevettazione, realizzata al fine di battere i potenziali concorrenti nella competizione divenuta per il mercato, in cui l’esclusiva di un certo diritto IP conferisce al vincitore un potere monopolistico o quasi tale in luce del principio winner-takes-all, innalzando imponenti barriere all’ingresso per i nuovi possibili entranti. Il diritto della concorrenza potrebbe, allora, assumere una funzione mitigatrice al fine di contemperare le esigenze del singolo operatore con l’interesse generale alla libera competizione nel mercato.
La tensione tra le leggi che regolano la concorrenza ed i diritti di proprietà intellettuale si acuisce nel caso delle tecnologie standardizzate, allorché queste trovino una protezione all’interno di brevetti c.d. essenziali (Standard Essential Patens o SEP). La standardizzazione tecnologica è un processo significativo e necessario per garantire l’interoperabilità e l’interscambiabilità dei prodotti, specialmente nei mercati digitali e in quello definito dell’Internet delle Cose (Internet of Things o IoT), garantendo una migliore qualità ed una maggiore scelta per i consumatori. Gli standard qualitativi definiscono le condizioni necessarie di elaborazione e fabbricazione che devono essere implementate nella realizzazione di un determinato prodotto, così come definite all’interno delle organizzazioni di normazione (c.d. Standard Setting Organizations o SSO). La presenza di standard consente alle imprese di poter operare sulla base di un comune denominatore, godendo dei reciproci ritrovati tecnologici, e, riducendo i costi di transizione, consente ai consumatori di poter spaziare nella scelta e nell’utilizzo di prodotti analoghi. I brevetti di tecnologie che si rivelano imprescindibili per il rispetto di uno standard sono considerati “essenziali” dalle SSO e intorno alla loro fruizione da parte degli operatori economici si sono da tempo sviluppate profonde riflessioni sia in dottrina che in giurisprudenza.
I titolari di brevetti essenziali mettono tendenzialmente a disposizione delle organizzazioni di normazione le tecnologie di cui sono detentori, impegnandosi con specifici accordi a permetterne l’utilizzo attraverso la concessione di licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (Fair Reasonable And Non Discriminatory o FRAND). Pertanto, le tecnologie comprese in uno standard dovrebbero essere accessibili a tutti gli utilizzatori potenzialmente interessati. Tuttavia, la disciplina degli accordi per la concessione di licenze e i limiti previsti per l’utilizzo dei brevetti SEP non sono esenti da opacità e sono sovente oggetto di controversie in sede giurisdizionale e davanti alle autorità garanti della concorrenza. Lo scenario attuale vede, infatti, un aumento progressivo dei contenziosi tra i titolari di brevetti SEP e gli utilizzatori degli stessi, allorché i primi rivendicano la violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale ed i secondi la necessità di competere sul mercato a valle della tecnologia in questione. Al contempo, gli stessi detentori dei brevetti finiscono per rivestire il ruolo di potenziali gatekeeper nei confronti delle imprese intenzionate a realizzare prodotti confacenti ad uno standard, potendo determinare il flusso di entrata nel mercato di riferimento rifiutandosi di cedere le licenze per il relativo sfruttamento.
L’integrazione di una tecnologia all’interno di uno standard rende, infatti, il relativo brevetto la sola alternativa percorribile per un produttore, esprimendo una conditio sine qua non per l’accesso al mercato. Tale assunto è stato condiviso in più di una occasione dalla Commissione Europea e dalla Corte di Giustizia, nonché dalle autorità e dalle corti statunitensi, che hanno qualificato come abuso di posizione dominante sia il rifiuto da parte di un titolare di un brevetto SEP di concederne la licenza a termini FRAND sia la richiesta di rimedi ingiuntivi avanzata da questi nei confronti di utilizzatori che si erano mostrati disposti a pagare canoni adeguati.
Le investigazioni della Commissione hanno sollevato complesse questioni giuridiche e di policy, che riguardano i limiti di un possibile sconfinamento del diritto della concorrenza nell’alveo di competenza della proprietà intellettuale e della libera iniziativa economica. Una volta impiegata la tecnologia cui il brevetto essenziale appartiene e realizzati gli investimenti necessari alla produzione, un’impresa potrebbe, infatti, venire a trovarsi in una situazione di hold-up non potendo ricorrere a tecnologie alternative, che potenzialmente la espone a condotte di sfruttamento da parte dei licenzianti. Nonostante l’assunzione di impegni in materia di concessione a termini FRAND, non sono pochi i casi in cui i titolari di SEP sono accusati di approfittare della situazione di necessità dei licenziatari per ottenere royalties ben superiori rispetto al valore intrinseco del brevetto. L’attività della Commissione ha evidenziato le discrasie talvolta esistenti tra diritto della concorrenza e diritto della proprietà intellettuale in questo contesto, frutto di una diversa prospettiva di azione e di valutazione dei valori in gioco, la cui consistenza è stata da ultimo testata anche dagli organi giurisdizionali.
Nel presente lavoro ci si propone di indagare la tensione tra le leggi che regolano la concorrenza ed i diritti di proprietà intellettuale, al fine di comprendere il ruolo che le prime, ed in particolare le norme sull’abuso di posizione dominante, possono giocare nel favorire la circolazione dei brevetti essenziali per accedere ad un determinato standard tecnologico. Ci si chiede, in particolare, fin dove dovrebbe spingersi l’intervento istituzionale pro-concorrenziale nell’interferire con la libera iniziativa imprenditoriale e quale ruolo dovrebbe assumere il diritto della concorrenza nei processi di creazione e diffusione delle novità tecnologiche.
Il presente lavoro è suddiviso in quattro capitoli.
- Nel primo si procederà a presentare il fenomeno dei SEP e le dinamiche dei processi di standardizzazione, ad offrire una panoramica generale sul rapporto tra proprietà intellettuale e intervento antitrust alla luce della normativa in vigore nell’Unione Europea e negli Stati Uniti, ed a illustrare, infine, il problema del patent hold-up e la portata (dibattuta) degli impegni FRAND.
- Nel secondo, si proverà ad inquadrare le condotte abusive dei titolari di brevetti SEP all’interno della cornice dei rimedi offerti dal diritto antitrust comunitario attraverso l’art. 102 TFUE. Particolare attenzione sarà posta sull’istituto del rifiuto a contrarre e sulla connessa teoria dell’essential facility elaborata dalle corti americane e poi seguita anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, di cui si ricostruirà la genesi e l’applicazione fatta dalla Commissione Europea nello specifico ambito della proprietà intellettuale.
- Nel terzo capitolo si proverà a calare la fattispecie del rifiuto a contrarre censurabile ex art. 102 TFUE nello specifico ambito dei brevetti essenziali, per verificare quale sia l’origine e la portata dell’obbligo a contrarre che la normativa antitrust vorrebbe imporre in capo ai titolari di SEP. Si proporranno tre letture diverse, che giustificano differentemente la sanzionabilità delle condotte dei licenzianti, riconducibile, rispettivamente, al verificarsi delle “circostanze eccezionali” elaborate dalla Corte di Giustizia nelle decisioni Magill, IMS Health e Microsoft, alla semplice essenzialità del brevetto o all’assunzione da parte del titolare di un impegno a concedere le licenze a termini FRAND con l’organizzazione di normazione. Sarà poi descritto l’iter compiuto dalla giurisprudenza comunitaria nell’equiparare la richiesta di ingiunzione inibitoria ad un rifiuto di licenza abusivo ai sensi dell’art. 102 TFUE, presentando alcuni quesiti rimasti tuttora irrisolti. Nell’ultima sezione del capitolo saranno, infine, richiamati gli orientamenti sorti in materia di SEP negli Stati Uniti, esponendo la principale case law ed evidenziandone l’evoluzione e i cambiamenti di approccio delle autorità garanti della concorrenza nel corso del tempo.
- Per concludere, il quarto capitolo sarà dedicato ad un commento delle più recenti proposte di regolazione da parte della Commissione Europea, ponendo l’accento su alcuni dubbi sollevati circa la loro necessità. Si cercherà poi di rispondere ad alcune domande cruciali che accompagnano tutta la stesura dell’elaborato, circa il rapporto tra libera concorrenza e incentivi all’innovazione, sul ruolo dell’autorità pubblica nella regolazione dei processi di sviluppo e sul ruolo che l’enforcement antitrust può avere in un contesto di regolazione più dettagliato.