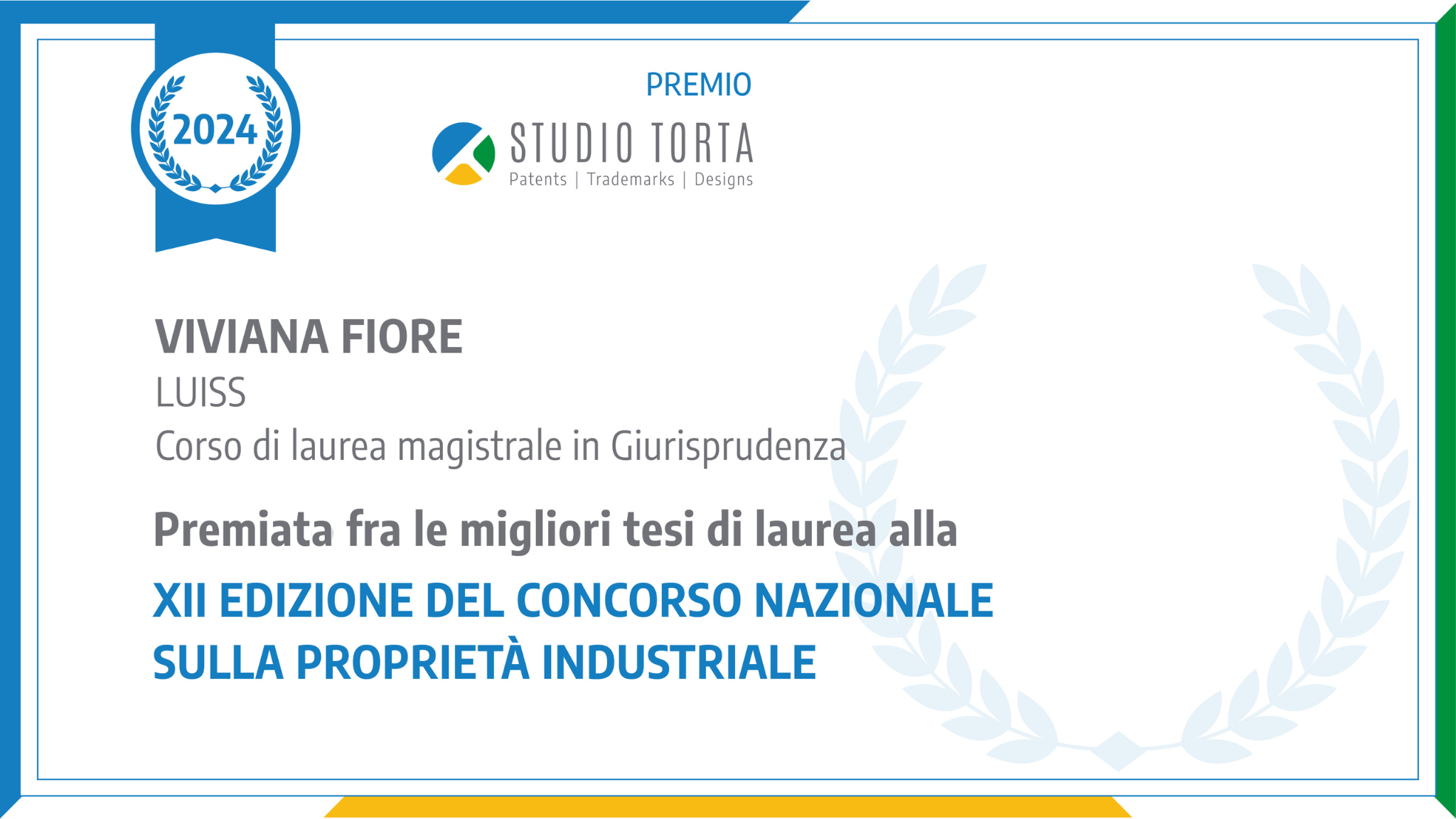L’e-commerce ed i problemi connessi alla sua evoluzione: la violazione del marchio ed il caso Louboutin-Amazon
Il presente elaborato si propone di analizzare l’evoluzione della disciplina relativa alla tutela dei marchi, alla luce dell’espansione di Internet nonché dell’e-commerce e dei c.d. marketplace, con un focus specifico sul caso “Louboutin – Amazon”.
Come ampiamente discusso all’inizio dell’elaborato, l’attività imprenditoriale è un’attività di relazioni che si sviluppa sul mercato, ove coesistono più imprenditori che producono e/o distribuiscono beni o servizi tra loro simili o addirittura identici. Nonostante la generale previsione – ex art. 41 Cost – di libertà di iniziativa economica e di concorrenza tra le imprese legittimi l’adozione, da parte degli imprenditori attivi sul mercato, di tecniche e strategie ritenute più appropriate al fine di ottenere un vantaggio rispetto agli altri operatori presenti sul medesimo mercato, è interesse generale che ciò non si traduca nella giustificazione di atti e comportamenti arbitrari (c.d. Pratiche commerciali scorrette) in grado di pregiudicare la logica pro-concorrenziale posta alla base del funzionamento dei mercati (c.d. Concorrenza perfetta). Per tale ragione, si è considerato di cruciale importanza intervenire introducendo un’apposita regolamentazione dei mercati – completa ed efficace in materia di concorrenza sleale – al duplice fine di ripristinare un locus mercatorum corretto e di assicurare l’uguaglianza sostanziale tra gli operatori sul mercato.
In particolare, nel contesto economico attuale, caratterizzato da una crescente intensificazione degli scambi commerciali e da un’innovazione continua, la competizione tra le imprese è stata notevolmente influenzata dalla rapida diffusione di Internet e dal suo utilizzo a fini commerciali. Questo scenario ha introdotto nuove sfide giuridiche, derivanti dalla necessità di adattare istituti giuridici originariamente concepiti per il mondo fisico ad un più attuale e moderno contesto virtuale.
Partendo da queste premesse, il capitolo I dell’elaborato esamina il marchio e la sua evoluzione. Infatti, in questo nuovo scenario digitale – in cui un ruolo chiave è attribuito alla riconoscibilità dei segni distintivi – si è assistito ad una crescita esponenziale di usi illeciti di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale. Tra questi ultimi, una parte preponderante ha riguardato il marchio, considerate le sue fondamentali funzioni: da un lato, la sua funzione distintiva e di provenienza, intesa come capacità di identificare un determinato prodotto o servizio in quanto proveniente da una specifica impresa; dall’altro lato, la sua attitudine alla valorizzazione dell’immagine delle imprese attraverso la sua funzione qualitativa e di garanzia dei prodotti e/o dei servizi; e ancora, la funzione comunicativa ed attrattiva cui assolve. Difatti, il marchio – disciplinato sia dall’ordinamento nazionale (artt. 2569-2574 del codice civile e codice della proprietà industriale) sia da quello comunitario (si pensi ai Regolamenti 2424/2015/UE e 1001/2017/UE nonché alla Direttiva 2436/2015/UE) ed internazionale (basti pensare al c.d. TRIPs) – attribuisce al titolare l’esclusività di un determinato segno – apposto su prodotti, confenzioni e contenitori destinati ai consumatori – che si pone come un monopolio tendenzialmente perpetuo, considerata la rinnovabilità della registrazione. L’ordinamento giuridico, tuttavia, consente ciò per ragioni sostanzialmente filo concorrenziali. Per tale motivo, tra l’altro, si è assistito ad un progressivo ampliamento del novero di entità suscettibili di protezione mediante la registrazione come marchi. Ad oggi, infatti, oltre ai marchi tradizionali – comunemente noti – costituiti da parole, loghi o combinazioni di entrambi, particolare importanza stanno assumendo i c.d. “nuovi marchi” o “marchi non convenzionali” o “marchi atipici”, quali marchi sonori, marchi di colore, marchi di posizione, marchi olfattivi e così via. Questi si discostano dai marchi convenzionali ed includono tipologie di segni distintivi meno comuni ma, ormai, sempre più rilevanti nell’ambito della tutela giuridica dei marchi.
Tale riconoscimento, in particolare, è avvenuto:
– Dapprima in via giurisprudenziale. Si pensi al caso Siekmann, uno dei leading case in materia: ivi la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito l’ammissibilità della registrazione di un marchio di tipo olfattivo – seppur non espressamente menzionato in alcuna dispozione – nonostante non fosse percepibile visivamente/ rappresentabile graficamente.
– Poi, mediante la previsione di apposite norme di riferimento tra cui – in quanto di nostro interesse – merita di essere richiamato il codice della proprietà industriale che, all’art.7 (modificato nel 2019), contiene un elenco esemplificativo di segni suscettibili di costituire validamente un marchio.
Tali marchi, in particolare, ancor di più rispetto a quelli tradizionalmente riconosciuti, possono essere oggetto di molteplici violazioni, sia nel mondo fisico che in quello virtuale (si pensi ad un marchio di colore, che facilmente potrebbe essere oggetto di violazione).
Nel capitolo II dell’elaborato è stato evidenziato come, in questo contesto, uno dei principali problemi sia rappresentato dalla contraffazione del marchio, fenomeno che incide negativamente sull’intero sistema economico. Difatti, per quanto la contraffazione sia un fenomeno radicato nella società ormai da decenni, con l’avvento dei mezzi di comunicazione e delle piattaforme di vendita a disposizione sul web – e soprattutto a seguito della pandemia da Covid19 – i c.d. professionisti del falso hanno trovato un ambiente favorevole per operare nel c.d. mercato parallelo, che alimenta l’offerta di prodotti non originali imitandone i segni distintivi. La contraffazione online ha così consentito a questi ultimi di raggiungere un numero illimitato di potenziali clienti e di perfezionare le proprie strategie di vendita.
Ad oggi, dunque, è possibile trovare numerosi articoli contraffatti in vendita su siti web, nonché su grandi piattaforme di distribuzione, di aste online, di marketplace e così via; tanto più se si tratta di marchi non ordinari.
Proprio in tale contesto, si colloca l’analisi del caso Louboutin c. Amazon, analizzata nella parte finale dell’elaborato, in cui viene affrontata la questione della responsabilità dei providers, in particolare ibridi – quali Amazon. Si tratta, nel dettaglio, di marketplace che presentano indistintamente le offerte commerciali proprie e di venditori terzi, apponendo il proprio marchio sugli annunci, occupandosi dello stoccaggio, del reso e della spedizione dei prodotti anche per conto di terzi.
Volgendo uno sguardo più attento alla fattispecie del caso concreto, esso concerne la proposizione di due cause (C-148/21 – pendente dinanzi al Tribunal d’arrondissement di Lussemburgo – e C-184/21- pendente dinanzi al Tribunal de l’enterprise francophone de Bruxelles del Belgio) successivamente riunite dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE. La disputa ha visto contrapporsi la maison di moda Louboutin – parte ricorrente – e la piattaforma Amazon, accusata di essere responsabile della contraffazione del marchio Louboutin.
Le accuse di violazione di marchio, nel dettaglio, prenderebbero le mosse dalla condotta posta in essere dal provider in questione, il quale avrebbe utilizzato, senza il consenso dell’attrice, i marchi di cui è titolare Louboutin, pubblicizzando e distribuendo, attraverso le proprie piattaforme online, prodotti presumibilmente contraffatti (scarpe con tacco recanti una suola rossa) messi in vendita da terzi (richiesta di accertamento della violazione dei propri diritti di marchio).
In particolare, il marchio oggetto di controversia è il marchio di posizione UE (8845539) e Benelux (874 489) – di cui è titolare Louboutin – registrato nella Classe 25 (per “scarpe con tacco – diverse dalle calzature ortopediche) e consistente nel colore rosso (Pantone 18–1663TP) applicato alla suola di una scarpa con tacco alto.
Nonostante il livello di integrazione tra la sua attività di vendita al dettaglio e il suo mercato, è chiaro che Amazon non diventi un venditore di beni di terzi ai fini del diritto contrattuale. Tuttavia, Tenuto conto del fatto che gli obblighi dei marketplace sono limitati ad alcuni doveri, come la rimozione delle offerte che violano il marchio su segnalazione e l’eventuale prevenzione di nuove violazioni, ciò che è stato chiesto alla Corte attiene alla questione se l’uso illecito di un segno da parte di venditori terzi su un marketplace online possa essere attribuito al gestore dello stesso, quando questo non abbia il controllo sull’uso del segno né sia a conoscenza della presunta violazione, ma agisca sia come rivenditore sia come operatore del marketplace.
Dunque, la Corte di giustizia dell’Unione europea è stata invitata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art.9, par.2, del Regolamento sul marchio dell’Unione europea 2017/1001/UE, rubricato “Diritti conferiti dal marchio UE”, in modo da verificare se ed, in caso affermativo, a quali condizioni il gestore di un marketplace– nel caso di specie un mercato ibrido – possa essere ritenuto responsabile, ai sensi dell’articolo sopra menzionato, per l’esposizione di annunci pubblicitari e la consegna di prodotti contraffatti messi in vendita e immessi sul mercato su iniziativa e sotto il controllo di venditori indipendenti che si avvalgono dei servizi di tale gestore.
Nell’analizzare la questione, la Corte è giunta ad una conclusione di segno opposto rispetto alla posizione assunta fino ad oggi in questioni dello stesso genere – quale, ad esempio, la nota pronuncia L’oréal c.eBay – in cui era stato negato con fermezza che la presenza di prodotti recanti marchi contraffatti su piattaforme di e-commerce costituisse “uso del marchio” da parte del gestore della piattaforma stessa, in violazione dei diritti altrui di proprietà intellettuale. In sostanza, la Corte ha più volte ritenuto che il semplice atto di fornire gli strumenti tecnici necessari per l’uso di un marchio non implicasse che il prestatore del servizio ne stesse facendo uso ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 del Regolamento 2017/1001/UE.
Al contrario, la Corte ha oggi ritenuto plausibile che un marketplace di tipo ibrido – in ragione delle sue peculiari caratteristiche – sia riconosciuto responsabile della violazione dei marchi derivante dalla vendita, da parte di terzi, di prodotti contraffatti.
In sostanza, la Corte ha considerato necessaria – ai fini della determinazione dell’eventuale responsabilità del provider – una valutazione di quella che è la percezione soggettiva dell’utente medio del fatto che le merci siano vendute per conto della piattaforma o per conto di una terza parte esterna.
Ad ogni modo, è importante sottolineare che, nella pratica, la sentenza della Corte si limita a rispondere alle domande, poste dai Tribunali nazionali, circa l’interpretazione delle norme europee; spetterà, dunque, proprio alle Corti nazionali la decisione finale nel merito delle due cause all’origine del procedimento.
A tal proposito, sembra opportuno menzionare una recente pronuncia proveniente dal Tribunale Regionale di Düsseldorf. Infatti, dopo circa otto mesi dalle conclusioni tratte dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea a seguito del caso Louboutin – Amazon, il Tribunale Regionale di Düsseldorf – in data 21 agosto 2023 – ha emesso una sentenza (14c O 67/23), relativa alla commercializzazione da parte di terzi, sul sito Amazon.de, di lampade a LED che violavano le norme su disegni e modelli comunitari. Questa decisione segna un momento significativo, rappresentando il primo caso noto di applicazione degli standard stabiliti dalla CGUE nel caso Louboutin – Amazon, esplicitamente richiamato dalla corte tedesca nel caso di specie. La sentenza, infatti, applica concretamente gli standard espressi a livello europeo dalla CGUE, sottolineando che le piattaforme ibride possono essere ritenute responsabili per violazioni di design o marchi, se queste promuovono direttamente l’uso degli stessi, anziché svolgere un mero ruolo di intermediari.
Per concludere, pare opportuno evidenziare come tale sviluppo proveniente dal Tribunale di Düsseldorf – insieme alla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea nel caso Louboutin c. Amazon – rappresenti un segnale importante nell’evoluzione della tutela della proprietà intellettuale all’interno del contesto digitale, aprendo nuove prospettive sulla responsabilità delle piattaforme online – e più nello specifico delle piattaforme di e-commerce ibride – e promuovendo una più ampia e completa salvaguardia dei diritti di design e marchi nell’ambito comunitario.
In ogni caso, considerata la forte rilevanza della questione, è comprensibile lo stato di incertezza su cui poggia la regolamentazione della responsabilità degli intermediari dei marketplace online; infatti, si tratta di un tema che richiede un’attenta considerazione e riforme ponderate, con la previsione di disposizioni che rafforzino la protezione dei consumatori, assicurando al contempo la concorrenza leale e promuovendo l’innovazione.